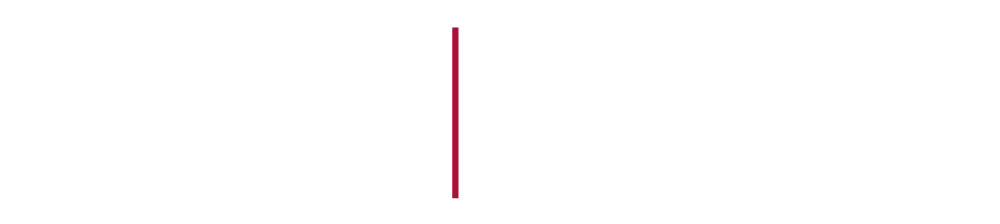Costituisce discriminazione (diretta o indiretta a seconda della valutazione del giudice nazionale in ordine al carattere neutro o meno della prassi) l’installazione, nei quartieri popolati in maggioranza da Rom, di contatori elettrici a un’altezza inaccessibile (6-7 metri) mentre in altri quartieri gli stessi contatori sono collocati ad una altezza consona (1-2 metri).
Commento a cura dell’avv. Alberto Guariso – servizio antidiscriminazione ASGI
Nonostante le tensioni che si affollano in Europa attorno al tema della discriminazione razziale la Corte di Giustizia, aveva avuto occasione di pronunciarsi sulla interpretazione della direttiva 2000/43 solo in due occasioni (sentenza Feryn C- 54/07, 10 luglio 2008 e sentenza Kamberaj C -571/10, 24 aprile 2012 ).
Alla terzo fascicolo che giunge alla sua attenzione la Corte (grande sezione) non si fa sfuggire l’occasione per una serie di puntualizzazioni di grandissimo interesse per l’assetto del diritto antidiscriminatorio e in particolare per la tutela contro le discriminazioni per razza e origine etnica di cui alla direttiva 2000/43.
La banalità della vicenda che ha dato luogo a queste affermazioni farà storcere il naso a quanti considerano il diritto antidiscriminatorio una specie di inutile orpello del “politicamente corretto”, ma dimostra invece la serietà con la quale la giurisprudenza comunitaria si prende cura di qualsiasi violazione – piccola o grande che sia – del diritto alla parità di trattamento.
Ecco cosa è accaduto: da oltre 25 anni un’azienda elettrica bulgara colloca i contatori, nei quartieri abitati in prevalenza dai Rom, a 6-7 metri di altezza, contro i 1- 2 metri degli altri quartieri, al fine dichiarato di prevenire allacciamenti abusivi che, secondo l’azienda, sarebbero opera prevalentemente di cittadini Rom. Una abitante del quartiere – non di etnia Rom – lamenta di subire una discriminazione determinata dalla appartenenza etnica della maggioranza degli abitanti del quartiere. Dopo una prima pronuncia negativa il Giudice si decide a sollevare questione pregiudiziale avanti la Corte ponendo una serie di quesiti.
Proviamo a sintetizzare almeno le più rilevanti risposte della Corte.
- L’art. 3 della direttiva, che ne definisce il campo di applicazione, si apre con l’espressione “nei limiti dei poteri conferiti all’Unione” (all’epoca “alla Comunità”). La società di distribuzione dell’energia sosteneva che una situazione come quella di cui alla causa principale (cioè il posizionamento dei contatori) non rientrava nell’ambito dei “poteri conferiti all’Unione” e chiedeva pertanto che la Corte arrestasse in limine l’esame della questione, ritenendola direttiva inapplicabile alla fattispecie. La Corte, nel replicare, avrebbe ben potuto limitarsi a considerare che l’art. 3, par. 1, lettera h indica come campo di applicazione della direttiva anche l’accesso a beni e servizi e che comunque sussistendo una direttiva che disciplina “l’efficienza degli usi finali dell’energia” (la direttiva 2006/32) una vicenda come quella in esame rientra appieno nell’ambito del diritto dell’Unione. Ma la Corte fa di più: al punto 42, ricorda che la direttiva 2000/43 “non è altro se non l’espressione, nell’ambito esaminato, del principio di uguaglianza, che è uno dei principi generali dell’Unione” sicché qualsiasi limitazione alla sua applicazione (ivi compreso l’incipit dell’art. 3) deve essere interpretata restrittivamente. L’affermazione potrebbe sembrare scontata, ma ha effetti di grande rilievo se si considera che dalla collocazione del divieto di discriminazione nell’ambito dei principi generali dell’Unione europea può discendere la sua applicazione diretta anche nei rapporti tra privati, cosi come riconosciuto dalla sentenza Mangold (C-144/0425, novembre 2005) a proposito del divieto di discriminazione per età.
- La persona che lamentava di subire lo svantaggio derivante dalla prassi discriminatoria dell’azienda aveva ripetutamente dichiarato (anche nelle osservazioni presentate alla Corte) di non appartenere all’etnia Rom. Si pone dunque il problema (e lo pone il Giudice della causa principale) se in una fattispecie di questo genere la direttiva possa comunque trovare applicazione; cioè (come spiega la Corte argomentando sulle varie traduzioni dell’art. 2) se ciascuno sia tutelato contro gli svantaggi dovuti alla “sua” appartenenza a una determinata etnia, o se ciascuno sia tutelato contro gli svantaggi comunque basati sulla appartenenza etnica, anche se di altri. La risposta della Corte è nel secondo senso e anche in questo caso non si tratta di una novità assoluta essendo null’altro che la riaffermazione della nozione di discriminazione associata introdotta dalla sentenza Coleman (C‑303/06, 17 luglio 2008). Si trattava tuttavia di una pronuncia rimasta sino ad ora isolata (anche se non si riscontrano pronunce di segno diverso) emessa in un caso in cui il collegamento tra soggetto discriminato (la madre lavoratrice) e l’appartenente al gruppo protetto (il figlio disabile) era particolarmente intenso. Nella sentenza in esame invece tra il denunciante-svantaggiato e il gruppo protetto non sussiste alcun particolare legame, se non quello di risiedere nello stesso quartiere: ma tanto basta. Ciò che rileva è che taluno sia svantaggiato “a motivo” (non soggettivamente inteso) della appartenenza etnica sua o di altri, come appunto avviene per tutti gli abitanti del quartiere in oggetto.
- Del tutto nuova è invece l’affermazione riferita alla quinta questione con la quale il Giudice nazionale chiedeva in sostanza quale fosse l’intensità del “trattamento meno favorevole” (nelle discriminazioni dirette) o del “particolare svantaggio” (nelle discriminazioni indirette) a fronte dei quali scatta la tutela antidiscriminatoria. Anche in questo caso la decisione della Corte è nel senso della massima tutela, tanto che la norma nazionale che limitava la tutela alle violazioni di diritti e interessi legittimi viene dichiarata incompatibile con la direttiva. Dunque anche una posizione che non sia direttamente qualificabile nell’uno o nell’altro senso e che si prospetti come mera situazione di fatto non altrimenti tutelabile può dar luogo a discriminazione. Tale costruzione conferma la grande flessibilità del diritto antidiscriminatorio che (a differenza di quanto accade per la tutela dei diritti fondamentali aventi la Corte Costituzionale e la CEDU) è utilizzabile per la tutela di qualsiasi situazione di svantaggio, piccolo o grande che sia purché connessa con un fattore vietato. Infatti anche le “piccole discriminazioni”, ricorda la Corte, precludono il raggiungimento di quegli obiettivi di solidarietà e coesione sociale che la direttiva persegue.
- La Corte torna poi sul medesimo tema della “intensità” del pregiudizio in un motivo successivo, trattando del “particolare svantaggio” che integra la discriminazione indiretta, in riferimento al quale il Giudice nazionale chiede se debba essere inteso come svantaggio “rilevante evidente e grave”, secondo cioè una nozione più restrittiva rispetto a quel “trattamento meno favorevole” che connota invece la discriminazione diretta. Secondo la Corte l’aggettivo “particolare” va inteso non nel senso di uno svantaggio “particolarmente grave” ma solo nel senso che questo colpisce “in particolare” – se pure mediante la prassi neutra – il gruppo protetto: ne resta confermato che sia il divieto di discriminazione diretta sia il divieto di discriminazione indiretta operano a fronte di qualsiasi svantaggio piccolo grande che sia. Ancora una volta la Corte ripete (punto 102) che se la nozione di discriminazione indiretta coprisse soltanto i casi rilevanti, evidenti o gravi di disuguaglianza “ne risulterebbero vanificati gli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione (punto 102).
- Altrettanto rilevanti sono le affermazioni in punto di onere della prova, posto che non è facile reperire nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea delle così ricche indicazioni al giudice nazionale su cosa debba intendersi per “fatti dai quali può presumersi che” ai sensi dell’art. 8 della direttiva. Il punto è di particolare rilievo perché, come noto, detta espressione indica i limiti dell’onere della prova del ricorrente, assolti i quali l’onere di dimostrare l’assenza di discriminazione si sposta a carico del convenuto (meccanismo che, a dispetto di quanto ritenuto dalla giurisprudenza nazionale maggioritaria, la Corte qualifica come “inversione dell’onere della prova”: cfr. punto 91). Ebbene, nella vicenda in esame, l’elenco dei fatti che il giudice nazionale potrà prendere in considerazione per valutare se trattasi di “fatti idonei a far presumere che” è particolarmente ampio: il fatto che la prassi in questione è posta in essere solo nei quartieri abitati prevalentemente da Rom; il fatto che la società abbia ripetutamente dichiarato che a suo avviso gli allacciamenti abusivi sono opera prevalentemente di Rom e che non abbia dato prova delle manomissioni dei contatori; il fatto che la prassi in questione sia “coatta e generalizzata” e indichi pertanto la convinzione della stessa società che gli abitanti del quartiere sono “nel loro complesso potenziali autori di tali comportamenti illegali”. Proprio quest’ultimo punto è di particolare rilievo ove si consideri che l’attribuzione di un comportamento illecito a un gruppo etnico “nel suo complesso” costituisce per la Corte prova rilevantissima che la prassi si fonda su “stereotipi o pregiudizi” ed è proprio per questo discriminatoria: come dire che per la Corte la rimozione dello stigma che deriva da detti pregiudizi è uno degli obiettivi fondamentali della direttiva.
Più in sintesi ulteriori importanti affermazioni:
- Non può esservi sovrapposizione tra le nozioni di discriminazione diretta o indiretta: in quella indiretta la prassi contestata deve essere prima facie neutra e dunque determinata da fattori diversi da quello vietato; senza che possa pretendersi né una particolare evidenza della neutralità, né, all’opposto, una manifesto collegamento causale con il fattore vietato (altrimenti si ricadrebbe nella nozione di discriminazione diretta). Il caso esaminato nella causa principale presenta tutte le caratteristiche per rientrare nella nozione di discriminazione indiretta ma la Corte rimette la scelta al giudice della causa principale.
- Nel caso in cui la prassi in questione fosse qualificata come discriminazione indiretta il convenuto potrà addurre una causa di giustificazione della disparità, ma questa andrà valutata restrittivamente e considerando separatamente la finalità perseguita (che potrebbe essere legittima) e dunque la necessità del mezzo impiegato (considerando a tal fine la disponibilità di altri mezzi tecnici per pervenire al medesimo risultato di prevenzione delle frodi) e comunque la proporzionalità di detto mezzo in rapporto al “legittimo interesse dei consumatori finali a poter consultare e controllare in modo efficace e regolare il loro consumo di energia” . Si conferma quindi che l’esame delle cause di giustificazione (analogamente a quanto avvenuto nella già citata sentenza Mangold) non può ridursi a sommarie considerazioni di asserito buon senso ma va operato in modo rigoroso, considerando separatamente i tre requisiti della finalità legittima, dei mezzi necessari e dei mezzi proporzionati.
Come si vede un patrimonio di riflessioni sul quale sarà necessario tornare più approfonditamente.
Servizio antidiscriminazione ASGI, progetto con il finanziamento della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
Le conclusioni dell’avvocato generale